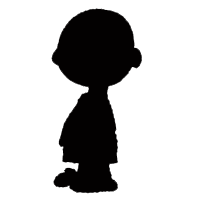
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
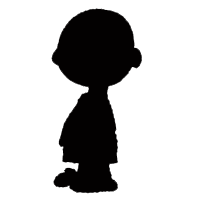
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
Si tu vales bene est, ego valeo.
La musica non insegna solo ad ascoltare, insegna anche la disciplina e il rispetto delle regole perché dove c’è rispetto c’è armonia. Una norma fondamentale posta alla base di tutte le cose.
Regole e Ordine sono il fondamento di ogni civiltà. Se ognuno comincia a fare di testa sua derogando ad ogni principio morale o giuridico, tutto si complica.
Se sono in fila alla posta, in negozio, dal prestinaio, al prelievo, devo rispettare la fila. Se entro in farmacia e noto che il pavimento è bagnato, evito di camminarci sopra per non far sprecare altri minuti di tempo all’inserviente che ha passato lo straccio per farmi trovare tutto pulito. Se cammino per strada e mi servo dei fazzoletti di carta per soffiarmi il naso, mi disfo del fazzoletto buttandolo nell’apposito cestino dei rifiuti. Se devo sbarazzarmi di un elettrodomestico non più funzionante, lo devo portare all’isola ecologica messa a disposizione dal comune per la gestione dei rifiuti ingombranti. Se commetto un reato devo essere punito. Se offendo, se sono stato sgarbato con una persona o gli ho arrecato un torto o un dolore, devo chiedere scusa. Se devo parcheggiare, arresto la macchina negli stalli di sosta blu, bianchi o gialli a seconda del posto riservato all’autoveicolo. Se ho bisogno del bagnoschiuma, devo acquistarlo, non devo rubarlo. Se per mangiare ho bisogno di guadagnare, devo lavorare.
Se, se, se.
Ad ogni necessità corrisponde un’azione e l’azione, per semplice che sia come l’acquisto di un pacco di caramelle, ha delle regole. Se mi approprio di una cosa senza versare il corrispettivo in denaro, commetto un furto. Se alzo la voce per impormi sull’altro e insultarlo, dall’altra parte avrò la stessa reazione. Se sporco l’ambiente in cui vivo, presto o tardi mi ammalerò di conseguenza. Se vedo gente coinvolta in una rissa, che sputa in strada, che passeggia svestita, che si comporta come se tutto gli è dovuto, che stupra e che uccide significa che l’Ordine è saltato, che l’anarchia (termine greco che vuol dire “senza governo”) fa da padrona.
Siamo abituati a considerare la regola come una limitazione, un fermo alla nostra libertà di espressione, di manifestazione e di agire, ma se non accettiamo e sottostiamo alla regola vuol dire che non ci piace l’armonia, che ce ne freghiamo della bellezza e del corso naturale e ontologico delle cose. Anche i fiori, gli alberi, i frutti della terra, prima di fiorire e maturare seguono un percorso logico e ordinario che fa parte del ciclo della natura. Non osano ribellarsi ad esso.
Un feto, per formarsi del tutto, impiega nove mesi (all’incirca 38 settimane). Non può derogare a questa regola, e ove ciò avviene è soggetto a complicazioni e in taluni casi anche alla morte.
Se metto a cucinare una pietanza e non le lascio il tempo che le occorre per insaporirsi, servirò a tavola una vera porcheria di mappazzone (e lo stomaco non ringrazierà di certo con relativo “vaffa” dai gemelli reni e dall’intestino).
Se eseguo una coreografia disarticolata, senza seguire il tempo, il ritmo, le battute della musica – tanto più se è studiata per coordinarsi con il corpo di ballo – quel che ne viene fuori sarà uno spettacolo non spettacolo (con annessa fuga del pubblico dalla sala).
Perché? Perché non c’è Ordine, non c’è Armonia, non è bello a vedersi (come dice Ale Maestra quando ci guarda eseguire la lezione del giorno e ciascuna di noi esegue una propria coreografia e non quella assegnata: «Ma k stat facenn?»¹).
Se invece di ribellarci alle regole ci fermassimo a pensare (per tornare ai famosi «se» dell’intro di questo articolo) che esse sono indispensabili per l’equilibrio di tutti (e quindi per il benessere della società che, per stare bene e funzionare in armonia, ha bisogno della sua “base ritmica”, del suo ordine; così come lo sport è strutturato su regole precise) allora forse la smetteremmo di fare quel che ci passa per la testa eludendo ognuno il proprio compito, che prima di parlare o di compiere un’azione o un gesto dobbiamo usare il cervello, che se ci siamo dati degli imperativi non è per scommettere su chi è più furbo, più veloce o simpatico a infrangere le norme, dandosi arie da grande artista o da gran seduttore², ma per imparare a convivere. Se a farlo e a comprenderlo è ogni specie animale, perché tu – uomo e animale – non sai farlo? Che razza di bestia sei?
Non ci lamentiamo (e soprattutto non polemizziamo) se poi le cose non vanno bene, non ci scandalizziamo se a scuola sono i genitori a rimproverare i maestri – e a far causa ai TAR³ - perché non hanno dato ragione ai loro figli, perché accadono incidenti per la strada o abusivismi nei territori e nelle case, se vengono esaltati come eroi e miti soggetti appartenenti a cosche mafiose, se vengono usurpati i parcheggi per i disabili, se le stazioni non sono più luoghi per viaggiare ma centri di bivacco o spaccio, se chi uccide, stupra, ruba, usa minacce o violenza lo fa perché avrà i suoi quindici minuti di successo nel mondo e si compiacerà per aver avuto la sua fama₄, se le persone (società) hanno smesso di seguire le regole, e quindi hanno rotto il meccanismo che consente di produrre e preservare l’Ordine e la Bellezza.
Reo del Caos è una mente non elastica, che non si conforma alle leggi della natura e che cerca in tutti i modi di cambiarle per scopi narcisisti convinto che a uscirne danneggiato sia l’altro e non lui, che è il vincitore.
Sforziamoci di vedere le cose da un punto di vista collettivo e non individuale contribuendo ciascuno nel suo, naturalmente, senza sopraffazioni.
Prendiamo esempio dalla musica, modello d’eccellenza dell’Armonia.
¹«Ma che state facendo?»
² In questo caso il termine vuol significare colui che trascina la folla ad emularlo e a fare altrettanto contravvenendo, anche inconsapevolmente, alle leggi etiche, religiose, sociali e naturali.
³ Acronimo di Tribunale Amministrativo Regionale
4 “Nel futuro ognuno sarà famoso al mondo per quindici minuti”, massima di Andy Warhol pittore statunitense
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Insultare. È diventata prerogativa di chiunque.
In televisione, per strada, in ospedale, sui social, a scuola, al bar, in treno, alla posta, in palestra, alla biglietteria, sulla spiaggia, in metro…
D’accordo, in alcuni luoghi lo si faceva anche prima dell’avvento dei social e dei telefonini, ora non fai neanche in tempo a scostare le lenzuola, buttarti giù dal letto per andare in bagno e ricevi subito il primo insulto della giornata. Praticamente il tanto caro e riguardoso buongiorno degli anni ’90 e precedenti che nel secolo ventunesimo si è dato un “ritocchino” e, come tutti i ritocchini, è diventato tarocco e volgare.
Le prime domande a bruciapelo sono: cosa ci trovate di tanto bello ad insultare? A cosa vi serve, ha per caso un’utilità? Dove la trovate la grinta necessaria di primo mattino per offendere la gente?
Denigrare gli altri è faticoso. A prima vista sembra l’azione più facile.
Coi social il gesto avviene spontaneamente, senza che ce ne rendiamo conto: è l’effetto tastiera che dona la sensazione di avere in mano uno “scettro del potere” perché non c’è nessuno che controlla quello che stiamo facendo e quello che stiamo dicendo (dove non c’è alcun tipo di limitazione non c’è padrone, sono io il padrone).
Questa bacchetta del potere, però, deve essere uno strumento con cui mi avvalgo per poter esprimere un’opinione; non è lo strumento che diventa il mio padrone e io il suo schiavo (situazione paradossale ma concreta perché mentre siamo convinti di avere il controllo, siamo noi, i padroni, quelli ad essere manipolati dall’oggetto).
Non ve ne faccio una colpa, perché come dicevo prima il gesto è diventato spontaneo, è come veder sbadigliare una persona e di rimando sbadiglio pure io.
La settimana scorsa poco ci è mancato che cadessi anch’io nella trappola. Zompettavo qua e là su Facebook e l’occhio mi cade su un commento poco carino su una persona. L’autore del succitato commento – devo dargliene atto – non si era espresso con parole grette, ma ha usato un tono da sfottò per dire la sua. Non lo nascondo: la cosa mi aveva mandato in bestia e mi sono detta “ora mi parte l’insulto”. Alt. Conta fino a dieci. Ti aiuta a trovare la calma e la frase giusta per esternare il tuo pensiero con garbo, senza offendere e magari, chissà, a fargli cambiare anche il punto di vista su quella persona ponendola su un’altra prospettiva. Così ho fatto, e lo scambio di opinioni si è concluso con un vero scambio di opinioni (no pernacchie e no linguacce) senza alzare i toni (ma a modificarli) e senza dileggio.
Immaginate se fosse accaduto il contrario: io cominciavo ad insultarlo, lui rispondeva all’insulto, io avrei continuato coi rimbrotti più duri e crudi e senza freni, poi si sarebbe aggiunto qualcun altro o forse più di uno per schierarsi dalla parte di uno o dell’altra, sarebbe sorta un’altra discussione che avrebbe portato in altra direzione col risultato di scordarci da dove eravamo partiti e perché, e con nulla di costruttivo in mano perché nessuno ha ascoltato nessuno, nessuno ha appreso nulla di nuovo e ognuno è rimasto della propria opinione. Ci saremmo solo ingrossati il fegato moltiplicando il numero dei radicali liberi nell’organismo col rischio di farci venire un infarto o un ictus e farci saltare tutto il sistema nervoso e simpatico (che nel frattempo sarebbe diventato antipatico date le circostanze).
Insultare sembra facile, ma è tutta apparenza. È logorante, e vale tanto per chi viene offeso quanto per chi offende. Non solo si spreca energia e tempo (spesso anche con gente con cui non vale la pena discutere), ma si sottopone il fisico ad uno stress inaudito (e invecchiate pure prima). Prima di tutto, quando si insulta non si impara nulla (non si impara manco ad essere più arroganti o più forti perché se uno è arrogante è arrogante e basta, e la forza non si misura col tono di voce), ci si avvelena la giornata (se parte male, l’arrabbiatura permeerà tutte le ventiquattro ore, ne influenzerà ogni aspetto e ci ridurremo a combinare poco o nulla, e quindi un giorno buttato all’aria), aumenta il senso di frustrazione (perché quel che avremmo detto o fatto nei confronti altrui non è mai abbastanza, il soggetto meritava più disprezzo), si diventa brutti (fate la prova allo specchio: fate una faccia arrabbiata e poi una che sorride, qual è più bella? Quale delle due vi fa sentire meglio?), si diventa cattivi e sempre più soli (passereste il vostro tempo con una persona che non ride mai, capace solo di lamentarsi?).
Infine – cosa più importante – non serve a niente (potrei anche capire lo sforzo di insultare se avessimo un riscontro favorevole, ma non c’è n’è. Morale: lasciate perdere tutto ciò che intossica voi e l’altro).
Se invece provassimo ad ascoltare quel che ha da dire chi ci sta dall’altra parte, senza pregiudizio (pre-giudizio, come dice il termine un giudizio fondato senza la diretta conoscenza dei fatti, delle cose e delle persone) e con pazienza, magari ci scopriremmo pure d’accordo con le sue ragioni (e forse alla fine ci starebbe pure simpatico). Conosco gente che si è persino sposata con chi non voleva nemmeno dividere lo spazio e l’aria assieme a quel tizio o a quella tizia, perché edificare dunque muri di gomma con quanti non la pensano come noi? Ok, non vi sto chiedendo di sposarvi col mondo intero, è giusto avere le proprie idee, il proprio partito politico, la propria squadra del cuore, le proprie passioni, le proprie opinioni, ma questo non comporta che devo tagliare fuori a priori chi non la pensa come me. Ascoltiamo prima cosa ha da dire, poi decidiamo se stare dalla sua parte, condividere il suo pensiero – “allargare” la mente in quanto ci consente di vedere il mondo con altre sfumature – oppure restare fedeli alle nostre ragioni. Mostrarsi ostili prima ancora che l’interlocutore apra bocca (rifiutarlo non solo per le sue opinioni ma perché è omosessuale, extracomunitario, laico, acattolico, ex tossicodipendente o alcolista, disabile ecc.) è come dire che non ci piace la salsa tonnata senza aver prima assaggiato la salsa tonnata.
Perché accettare di presenziare ad una conferenza o a un dibattito se il motivo per cui lo voglio è quello che il pubblico stia a sentire solo me e non gli altri partecipanti? Perché starmene tutto il giorno a chattare solo per il gusto di polemizzare e criticare l’operato e le scelte altrui e, invece, non trasformarlo in pretesto per cercare un confronto costruttivo (hai visto mai che può partire anche un progetto lavorativo e di crescita collettiva)?
Sarà che sono una persona curiosa ma se c’è una cosa che mi fa divertire come una bimba che sta per recarsi alla festa di compleanno della sua amichetta è ascoltare dialoghi (improvvisati, sui treni, in libreria, al supermercato, nelle piazze), discussioni (conferenze, associazioni culturali, laboratori, palestre), storie di quartiere, assistere a siparietti delle persone (per strada, nei condomini, nei parcheggi), insomma raccogliere materiale dalla vita di tutti i giorni per imparare anche dalle piccole cose.
Brevemente: faccio parte di un gruppo di condivisione di libri e di letture ed ogni mese ci ritroviamo (e ci ri-scopriamo) a commentare un libro tra quelli più votati su una rosa di cinque testi a tema comune. In questo gruppo di appassionati del leggere ad ogni incontro, durante la discussione, c’è un acceso scambio di opinioni tra una ragazza e un signore. Ripeto: scambio, non guerriglia su chi ha ragione e chi ha torto (anche se qualcuno, vedendoli, potrebbe pensare che si stanno tirando per i capelli; in realtà è solo passione per i libri, fidatevi. Non ci siamo mai picchiati). Assistendo a questi dibattiti non si può fare a meno di non ridere. V. e G. sono davvero esilaranti e l’aspetto più eccitante è proprio questo confronto di opinioni, riflessioni, interscambi empirici che, seppur “scaldano” gli animi (rendendo il dibattito una sit-com), il risultato finale è quello di uscirne più arricchiti e di avere una visione del mondo secondo infinite prospettive (ascolti, apprendi, ti adattarti a tutto quel che ti circonda, e comprendi).
Azzardo: anche da uno scemo si può imparare (cosa vuoi imparare da uno scemo? vi starete chiedendo. Per esempio a non abbassarsi al suo livello).
Bisogna che l’essere umano sia come una spugna: deve assorbire tutto e lasciar trasudare ciò che non gli occorre.
È vero, come cantava Mia Martini la gente è strana, ma lo spettacolo del mondo sta in questo. E se capita anche a me che talvolta le persone mi fanno arrabbiare e mi sale la voglia di dirgliene quattro, alla fine mi dico che non è insultandole che le aiuto a diventare più belle.
Jean Jacques Rousseau diceva che l’uomo nasce buono, è la società a renderlo cattivo. Non la voglio una società vecchia, amareggiata e cattiva. Pensate prima di agire o aprire bocca.
Insultare è faticoso, inutile, insalubre e non arreca nulla di buono.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
C’è un momento della giornata che preferisco assaporare con tutta calma: sedermi a tavola per fare colazione. Me lo godo il più possibile, senza subire l’ansia di darmi una mossa per stare al passo con gli impegni del giorno. Quello che avviene dopo è un casino. È un continuo stato di apnea che mi lascia addosso la sensazione di aver fatto tutto e di non avere fatto niente, quindi mi ritrovo a sera a fare i conti con quello che ho portato a termine (e di come l’ho portato a compimento) e con le cose che ho rimandato di fare. Per mancanza di tempo.
Il tempo sembra non essere mai abbastanza. Anche adesso che sto scrivendo avverto la pressione di sbrigarmi a completare il pezzo. Per quale motivo? Che fretta c’è? Perché il cervello si è ormai adeguato ai ritmi del presente, un presente informatizzato, sempre più tecnologico, che vuole che gli esseri umani siano macchine e non esseri umani; perché c’è bisogno di correre, produrre, aumentare il PIL, moltiplicarsi, tenersi impegnati, avere sempre qualcosa da fare per non essere bollati come “nullafacenti” o come “quell’essere inutile”.
Premesso che siamo tutti d’accordo sul fatto che dare il proprio apporto per la comunità è sempre un’azione utile, sia che lo si faccia con l’intelletto (avanzo una proposta, do una mia opinione, lancio una iniziativa) sia che lo si faccia in maniera concreta, col sudore e con la fatica. Tocca capire quante di queste azioni sono veramente utili e quante no.
Ho la sensazione che se affidassimo le due cose alle braccia della bilancia il peso graverebbe di più sulle seconde.
Prima che creassi questo blog c’era una paura che avvertivo nell’aria (presentimento che è diventato certezza). Il fenomeno social. Non avevo mai frequentato prima d’ora nessun tipo di social network, non solo perché li reputavo e li reputo ancora di una tristezza infinita (la solitudine è spaventosa in quel mondo lì), ma per la quantità di cattiveria che prolifera e si accumula generando montagne di spazzatura. Ebbene, fino a che questa sorta di macchina tritatutto si limitasse a produrre pochezza e inutilità nella sua monade senza coinvolgere la vita reale, le cose da quest’altra parte della barricata potrebbero pure funzionare (se non proprio al meglio comunque tenendoci un po’ a distanza dalla schifezza), il problema sta nel fatto che accade tutto il contrario. Il mondo di Facebook, Instangram, Tik Tok, X, Youtube, Telegram, WhatsApp (il mondo internet) è diventato “realtà”, ed essendo questo un “tipo” di realtà che, per sua natura, è veloce, abbiamo cominciato tutti a correre e non ci ferma più nessuno.
Ma velocità non è sinonimo di qualità. Tutt’altro. È il suo contrario. È quantità senza qualità, senza contenuti e senza sostanza. Come la maggior parte dei programmi in TV, come gran parte delle canzoni, delle informazioni, dei dialoghi, e non da ultimo dei libri. Si assiste ad un impoverimento del verbo, del corpo dei messaggi, dei testi; gli stessi brani delle canzoni sono svuotati di senso e la parola non è più uno strumento per creare storie, poesie, immagini, emozioni, ma è usata solo per comporre il testo, non per accompagnare e accompagnarsi alla musica creando un’armonia di suoni. La musica di oggi è tutto un bum, bum, bum, un rumore mono-tono e (peggio ancora) uguale a tutti i cantanti. C’entrano i talent (Amici, XFactor, The Voice e altro)? C’entrano le case discografiche? C’entrano internet, gli influcencer, gli youtuber, i tiktoker? Perché le canzoni del passato – e gli album dei grandi artisti del passato – ogni volta che le ascoltavo, sin dalla prima strofa, mi facevano partire in testa dei film narrandomi storie con cui si potevano scrivere pagine di romanzi? Perché accendevano l’immaginazione e adesso non si riesce a capire manco mezza frase di quello che cantano ‘sti cantanti?
Stesso discorso si declina con i libri. Basta iscriversi ad una di queste piattaforme (Wattpad, IlMioLibro, Open, BookTribu) oppure essere in lizza nei concorsi letterari (il più noto è il Premio Italo Calvino che ha lanciato tantissimi autori nel panorama editoriale) che eccoti pronti sui banconi delle librerie, o a fare la loro bella mostra nelle vetrine, libri di nuova generazione belli e sfornati. In tutta sincerità a me sembra che occupino solo spazio nelle scansie, di questo passo con tutti i testi di saggistica, cucina, romanzi, auto aiuto, libri “scritti” da calciatori, vip e influencer che vengono pubblicati ogni giorno, le librerie saranno costrette a chiudere ogni mese per rifarsi il look e darsi una ristrutturazione per quintuplicare gli scaffali. E poi per cosa? Per leggere parole masticate da altri autori prima di loro che cambiano solo nella forma e nello stile ma che, nella sostanza, sono sempre le stesse storie con le stesse ambientazioni e gli stessi personaggi? Quanti di questi testi raccontano la realtà (quella reale, non quella di internet o le fiction)?
Così nel campo del giornalismo. Quand’ero piccola gli addetti all’informazione erano esclusivamente la carta stampa, la radio e la televisione (nello specifico, i telegiornali). La notizia veniva resa nota, e per quel giorno era tutto. Seguivano aggiornamenti all’occorrenza.
Nel 2025 (così come dagli anni 2000 in poi) la notizia del giorno non è più la notizia del giorno, ma la notizia del mese. C’è una differenza di proporzioni, si predilige la quantità piuttosto che concentrarsi sulla vera notizia (una saturazione di programmi televisivi titolati senza alcuna distinzione tra loro che servono solo a farsi concorrenza tra giornalisti). Anche a voler guardare un bel film prima di andare a nanna, come se ne davano in onda all’epoca, non lo si trova manco a impiccarsi. Nel piccolo schermo impazzano reality (dove anche qui di reale c’è poco e niente), fiction, programmi di inchiesta o approfondimento (quante volte dobbiamo scaldare ‘sta minestra?) e talk show politici (più che talk show andrebbero definiti per quello che sono davvero, ovvero killer show e hit show, più genericamente cumulabili nella categoria degli horror show).
Ora, è ovvio che tutta questa scorribanda del progresso, di internet, dell’avanzamento tecnologico, della informatizzazione di ogni aspetto della vita (si pensi alla giustizia dove il deposito degli atti e le udienze avviene online, ma anche le ricette mediche, l’invio dei modelli della dichiarazione dei redditi, così come la richiesta delle istanze da parte del cittadino che deve, obbligatoriamente, essere munito dell’identità digitale) abbia cambiato il nostro modo di vivere, di pensare e di agire, sia per ciò che concerne la sfera individuale ma, soprattutto, il nostro rapporto con gli altri. Non siamo più umani, siamo dei robot. Ci siamo trasformati in macchine per produrre (non creare, ma produrre), sporcare, accumulare, scansare, generare entropia in nome del Dio Denaro disconoscendoci e facendoci la guerra tra di noi. Detto in altro modo: ci stiamo (auto)distruggendo.
Discutiamo del conflitto tra Gaza e Israele, della Russia contro l’Ucraina, ma non ci accorgiamo che prima di parlare della guerra che accade in Europa e in Oriente (facendo finta che ci interessi qualcosa e sempre facendo finta di trovare delle soluzioni) dobbiamo preoccuparci della guerra che ci stiamo facendo tra di noi tramite questo sesto potere (social media) che incide non di poco sul nostro comportamento. Ci accavalliamo nelle opinioni, sgomitiamo, insultiamo, sputiamo in faccia quando non siamo d’accordo con l’altro perché quello che diciamo noi è legge e non ammettiamo il confronto, facciamo a gara a chi urla di più, a chi vende più libri, a chi fa più concerti (e poi cade in depressione), a chi recita in più film o a teatro, o a chi scrive l’articolo più chic e lo scrive per prima per la sua testata (scivolando in errori di battitura), col risultato di non aver fatto niente di utile per la società (a parte blaterare tanto per il piacere di dare fiato alla bocca) e di trovarsi con un nulla di fatto in mano, che è lo specchio del vuoto assoluto dell’era contemporanea che siamo costretti a sopportare per sopravvivere. L’ “utilità” è confusa con lo stare sui social, presenziare agli horror show (il più delle volte per promuovere un disco, uno spettacolo, un libro, un programma) e “dire la propria”, che poi non è mai un esprimere la propria opinione perché tanto la mia opinione è diventata l’opinione di tutti, e quando non è più di tutti diventa pretesto per litigare e scatenare polemiche senza giungere ad un esito. Basta scorrere le interviste di un qualsiasi Vip: letta una, le altre sono identiche. Quello che dici te, lo dico pure io. Nulla di nuovo all’orizzonte.
Fingiamo di concentrarci sui problemi che ci affliggono quando, al contrario, siamo solo concentrati su noi stessi e su cosa inventarci per stare al centro dell’attenzione e far parlare di noi. Quando ciò non avviene – o non c’è riuscita nell’intento di lasciare traccia di sé – si passa alla violenza. Anche quest’ultima viene fatta passare come un atto di ribellione nei confronti di un regime governativo che tende a riportare alla luce la politica dei fasci, ma il movente è molto più complesso di quanto appare.
Il nucleo della questione rimane invariato: se non ci fermiamo a pensare (ma pensare come azione, non come prima coniugazione del verbo pensare e stop), se non la smettiamo di correre per arrivare sempre primi o per il terrore di essere dimenticati e di non lasciare segni del nostro passaggio sulla Terra, non arriveremo a concludere niente se non continuare ad alimentare la merce del nulla, un passa-tempo in cui sguazzare che, invece di ancorarci alla realtà, mette sempre più distanza tra noi e l’esistenza, rendendoci esseri cattivi, assenti, deviati, depressi e “meccanizzati”.
E quel che è peggio manipolati dal sistema economico del consumismo, un enorme contenitore cavo di contenuto, che ha finito col consumarci.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Un giorno, durante una lezione al laboratorio di scrittura¹, sorse una discussione.
Tutto partì dal racconto di un frequentante dove, al termine della lettura, scoprimmo che nella storia non accadeva nulla.
L’animatore del laboratorio (che da questo momento chiameremo S.) gli chiese se ci fosse un seguito. Il ragazzo – di cui non ricordo il nome ma il titolo del racconto – gli rispose stoicamente no.
Scoppiò l’insurrezione. Non era possibile e nemmeno immaginabile pensare che in una storia non potesse accadere nulla. Il frequentante, con una imperturbabilità spiazzante (tanto quanto il suo ragionamento, come scoprimmo più tardi) rispose che non ci vedeva nulla di male se in una storia non succedeva nulla perché, stando a quanto disse, nella realtà ci sono molti contesti in cui non accade niente. Gran parte dei partecipanti assieme a S., ovviamente, non era d’accordo. Solo a discussione conclusa qualcuno cambiò opinione, tra i restanti ci fu chi rimase fedele al proprio convincimento e chi iniziò a titubare (quando dico titubare significa che cominciò a farsi cogliere dal dubbio, e a riflettere prendendo in considerazione la circostanza che ci era stata appena raccontata).
La cosa mi colpì. E mi colpì la tenacia del ragionamento.
S. era convinto che quello che leggevamo non era letteratura, pertanto, se volevamo scrivere e sentivamo l’esigenza di raccontare qualcosa, dovevamo saper sondare ogni aspetto in ogni suo dettaglio. Solo così saremmo riusciti a cogliere l’essenza di ciò che ci circonda avvicinandoci alla verità (e quindi al significato dell’esistenza).
Il suo era un laboratorio che caricava di molta rilevanza il particolare (una scarpa slacciata, la guglia di un campanile, il colore, la forma, la consistenza dei petali di un fiore, un particolare tipo di odore o cibo ecc.). Ricordo che durante il corso ci obbligava a vivere delle vere esperienze sensoriali legate al gusto (c’era chi portava la pizza, torte fatte in casa, panini, rustici, che mangiavamo nei momenti di pausa o a fine lezione), agli odori (il corso si svolgeva anche nei parchi, avevamo una sede fissa ma capitava che ci spostassimo per la città), ai suoni, al tatto. Una volta trascorremmo mezz’ora a toccarci le mani col nostro/a compagno/a di banco prima di metterci a scrivere allo scopo di familiarizzare con le sensazioni che suscitava quel gesto e affidarle al foglio bianco.
S. era dell’idea che troppe parole nei libri sono sprecate. Non erano le parole ad essere importanti, ma le immagini e i dettagli.
E il modo in cui venivano descritti o la descrizione di una scena che si svolgeva tra due persone diceva tante cose, senza andare a sovraccaricare il testo con le parole o le metafore.
Quella era la Letteratura. La vita. L’essenziale.
«Non me lo devi dire, me lo devi far vedere» diceva sempre quando uno dei frequentanti si perdeva nella sovrabbondanza delle similitudini, dei chiasmi, delle iperbole, delle anafore. Il personaggio era una identità aliena(dal latino: alienus “altrui”) che non corrispondeva all’autore.
Aveva sentimenti, provava emozioni come la mano che lo generava, ma non erano la stessa persona (il personaggio non era l’alter ego dell’autore o il suo avatar). Erano persone ben distinte, con i loro difetti, pregi, caratteri. Perché ogni persona è unica, ha la sua caratterizzazione. Non si può ripetere.
Anche la rabbia, il dolore, l’amore, la compassione, l’odio, la gelosia, avevano la loro pellicola. Non erano parole che servivano a costruire allegorie per riempire le pagine del quadernetto. Tutto quello di cui c’era bisogno era “a portata d’occhi”. Bastava fotografarlo con lo sguardo.
Sono passati quasi vent’anni dalla frequentazione del laboratorio di scrittura con S., dopo tanto tempo mi chiedo se non avesse ragione lui quando banchettavamo argomentando di letteratura e scrittura. Del resto, alcuni grandi autori del passato, prima di essere scrittori, erano anche fotografi, disegnatori, pittori.
Come a dire: ho visto una cosa, te la descrivo così come l’ho vista, con tutte le sue minuzie. Adesso trai le tue conclusioni. Lasciando a me (lettore) il compito di tirare fuori le mie impressioni, tu (autore) mi doni il massimo della libertà: quella di far decidere a me il finale della storia. Tu (autore) sei il tramite, lo strumento, l’ “occhio” che mi consente di osservare (badate bene: osservare, non guardare) la scena che si sta svolgendo davanti a me e di darne un’interpretazione (è la magia del teatro).
Ne discende che quella storia, o quel libro, non sarà «il romanzo di» ma «un romanzo» che reca con sé più mondi possibili e infiniti.
Chiudiamo parentesi e facciamo un passo indietro. Torniamo al testo in cui non accade nulla.
Il racconto si chiamava “Prosit”. Un gruppo di gente si recava ad una cerimonia e, al di là dei brindisi e dei festeggiamenti accompagnati dai dialoghi, non succedeva appunto nulla.
Il primo a far notare questa cosa all'autore fu S., l'artefice del racconto gli disse ciò che ho scritto poc’anzi. Non per forza nella vita di alcune persone accade qualcosa.
Tralascio la lunga discussione che ne seguì soffermandomi, invece, sul pensiero dell’allora nostro compagno di laboratorio (che si stava allineando, come tutti i discepoli, su quello di S.).
Se la letteratura è (ed era, come stavamo imparando a concepirla) un insieme di esperienze individuali con cui è dato interfacciarsi per comprendere meglio se stessi e gli altri attraverso il proprio vissuto, considerata la molteplicità degli individui nel mondo e sempre tenendo bene a mente che ogni essere è unico, come è unica la sua esistenza e la direzione che essa imbocca, è allora possibile che taluni frammenti non abbiano il loro baluginio o non subiscano scossoni. La letteratura è un vasto bacino che comprende migliaia di “utenze”, il numero dei suoi abitanti è pari a quello che c’è sulla Terra; ora, se essa (letteratura) rispecchia in toto la realtà (perché racconta di esseri viventi che mangiano, bevono, fanno l’amore, coltivano degli hobby, si recano a lavoro o a scuola ecc.), altrimenti fittizia, perché dovremmo mai scandalizzarci se nella vita di alcune persone non succede niente di niente?
Rimasi rapita dal ragionamento (che non faceva una piega).
Al di là di alcuni (esigui) generi letterari – come i gialli e le favole – dove per forza deve accadere qualcosa, in tutti gli altri casi è possibile – se non doveroso – derogare alla regola.
La letteratura parla, e ci parla di noi. Siamo tanti, c’è chi è romanzo e chi è racconto. Non siamo tutti lo stesso libro.
Ho letto testi dove non capitava nulla, e testi opulenti di colpi di scena. I secondi, è retorico dirlo, sono quelli che rispetto ai primi riscuotono più successo.
Cos’è la letteratura?
¹ In un mio precedente post avevo parlato di laboratorio di scrittura creativa. In realtà si trattava solamente di un laboratorio di scrittura che non aveva nulla a che fare con la creazione di una storia, in quanto ci si limitava a riprodurre la realtà restando fedeli quanto più possibile ad essa.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Questo è un articolo muto. Non fraintendete. Per muto intendo da parte della scrivente, perché quello che leggerete è un pezzo ricco. Molto ricco.
Denso, pieno di contenuti. Di sostanza. Di quelli che andrebbero scritti più spesso e scritti bene, proprio come l'autore di questo script.
Si dicono tante parole, oserei dire che si lanciano tante di quelle parole come si lanciano le bombe in guerra. Ed in guerra siamo. Tutti i giorni. Anche prima che scoppiasse la guerra tra Russia e Ucraina e prima della guerra tra Palestrina e Israele. Si lanciano parole senza pensare, come bombe, appunto. Abbiamo smesso di allenare il cervello, preoccupati solo di non contrarre il muscolo della favella. Colpa dei social? Di questi maledetti mezzi di "comunicazione"? Di programmi televisivi, di canzoni, di informazioni, di testi privi di contenuto? Non lo so. Ho come l'impressione che le parole siano riciclate, che abbiano il sapore di qualcosa di già detto, di già sentito... ultimamente questa sensazione mi arriva anche dai libri (è una cosa brutta, non c'è niente da ridere o di cui sghignazzare).
Sono passati pochi giorni dell'anno e mi tocca far ordine in tante cose. È difficile. Molto.
Voglio cominciare dai libri, dalle persone, da notizie buone, scritte con nuove parole, che siano sinonimi di crescita.
Voglio iniziare con le stesse parole e gli stessi pensieri di cui si è servito Alessio. L'ho conosciuto appena, direi che l'ho "sfiorato", come quando si fanno scivolare i petali di un fiore sulle guance. Sono delicati, una carezza del vento che desidera toccarti la pelle, saggiarne la consistenza, scoprire se quella corazza è abbastanza resistente per l'anima che vi pulsa dentro.
Alessio è così. È una carezza. Ti accarezza con la voce, con le parole, con la sua presenza. Ti abbraccia, ti fa sentire protetta.
Condividevamo un gruppo di lettura (parlo al passato perché è in procinto di partire) ed era, è un gruppo assai bello. Bello e esagerato, vitale, galvanizzante, colorato... un gruppo Wow!
Peserà molto la sua assenza.
Questa mattina mi hanno girato il suo articolo, un pezzo molto forbito riguardo all'esercizio della lettura. Analisi più dettagliata non poteva esser eseguita. Ve lo voglio proporre. Leggetelo bene, assaporate bene le parole come se steste masticando una mela o un piatto di pasta asciutta. Prendetevi tutto il tempo necessario, ne vale veramente la pena. E qui mi fermo. Perché ho già detto troppo, o forse, non ho detto niente.
L'articolo è visionabile a questo link.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Accedi o Registrati per commentare l'articolo