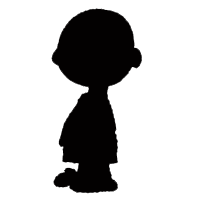
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
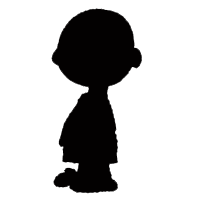
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
C’è un momento della giornata che preferisco assaporare con tutta calma: sedermi a tavola per fare colazione. Me lo godo il più possibile, senza subire l’ansia di darmi una mossa per stare al passo con gli impegni del giorno. Quello che avviene dopo è un casino. È un continuo stato di apnea che mi lascia addosso la sensazione di aver fatto tutto e di non avere fatto niente, quindi mi ritrovo a sera a fare i conti con quello che ho portato a termine (e di come l’ho portato a compimento) e con le cose che ho rimandato di fare. Per mancanza di tempo.
Il tempo sembra non essere mai abbastanza. Anche adesso che sto scrivendo avverto la pressione di sbrigarmi a completare il pezzo. Per quale motivo? Che fretta c’è? Perché il cervello si è ormai adeguato ai ritmi del presente, un presente informatizzato, sempre più tecnologico, che vuole che gli esseri umani siano macchine e non esseri umani; perché c’è bisogno di correre, produrre, aumentare il PIL, moltiplicarsi, tenersi impegnati, avere sempre qualcosa da fare per non essere bollati come “nullafacenti” o come “quell’essere inutile”.
Premesso che siamo tutti d’accordo sul fatto che dare il proprio apporto per la comunità è sempre un’azione utile, sia che lo si faccia con l’intelletto (avanzo una proposta, do una mia opinione, lancio una iniziativa) sia che lo si faccia in maniera concreta, col sudore e con la fatica. Tocca capire quante di queste azioni sono veramente utili e quante no.
Ho la sensazione che se affidassimo le due cose alle braccia della bilancia il peso graverebbe di più sulle seconde.
Prima che creassi questo blog c’era una paura che avvertivo nell’aria (presentimento che è diventato certezza). Il fenomeno social. Non avevo mai frequentato prima d’ora nessun tipo di social network, non solo perché li reputavo e li reputo ancora di una tristezza infinita (la solitudine è spaventosa in quel mondo lì), ma per la quantità di cattiveria che prolifera e si accumula generando montagne di spazzatura. Ebbene, fino a che questa sorta di macchina tritatutto si limitasse a produrre pochezza e inutilità nella sua monade senza coinvolgere la vita reale, le cose da quest’altra parte della barricata potrebbero pure funzionare (se non proprio al meglio comunque tenendoci un po’ a distanza dalla schifezza), il problema sta nel fatto che accade tutto il contrario. Il mondo di Facebook, Instangram, Tik Tok, X, Youtube, Telegram, WhatsApp (il mondo internet) è diventato “realtà”, ed essendo questo un “tipo” di realtà che, per sua natura, è veloce, abbiamo cominciato tutti a correre e non ci ferma più nessuno.
Ma velocità non è sinonimo di qualità. Tutt’altro. È il suo contrario. È quantità senza qualità, senza contenuti e senza sostanza. Come la maggior parte dei programmi in TV, come gran parte delle canzoni, delle informazioni, dei dialoghi, e non da ultimo dei libri. Si assiste ad un impoverimento del verbo, del corpo dei messaggi, dei testi; gli stessi brani delle canzoni sono svuotati di senso e la parola non è più uno strumento per creare storie, poesie, immagini, emozioni, ma è usata solo per comporre il testo, non per accompagnare e accompagnarsi alla musica creando un’armonia di suoni. La musica di oggi è tutto un bum, bum, bum, un rumore mono-tono e (peggio ancora) uguale a tutti i cantanti. C’entrano i talent (Amici, XFactor, The Voice e altro)? C’entrano le case discografiche? C’entrano internet, gli influcencer, gli youtuber, i tiktoker? Perché le canzoni del passato – e gli album dei grandi artisti del passato – ogni volta che le ascoltavo, sin dalla prima strofa, mi facevano partire in testa dei film narrandomi storie con cui si potevano scrivere pagine di romanzi? Perché accendevano l’immaginazione e adesso non si riesce a capire manco mezza frase di quello che cantano ‘sti cantanti?
Stesso discorso si declina con i libri. Basta iscriversi ad una di queste piattaforme (Wattpad, IlMioLibro, Open, BookTribu) oppure essere in lizza nei concorsi letterari (il più noto è il Premio Italo Calvino che ha lanciato tantissimi autori nel panorama editoriale) che eccoti pronti sui banconi delle librerie, o a fare la loro bella mostra nelle vetrine, libri di nuova generazione belli e sfornati. In tutta sincerità a me sembra che occupino solo spazio nelle scansie, di questo passo con tutti i testi di saggistica, cucina, romanzi, auto aiuto, libri “scritti” da calciatori, vip e influencer che vengono pubblicati ogni giorno, le librerie saranno costrette a chiudere ogni mese per rifarsi il look e darsi una ristrutturazione per quintuplicare gli scaffali. E poi per cosa? Per leggere parole masticate da altri autori prima di loro che cambiano solo nella forma e nello stile ma che, nella sostanza, sono sempre le stesse storie con le stesse ambientazioni e gli stessi personaggi? Quanti di questi testi raccontano la realtà (quella reale, non quella di internet o le fiction)?
Così nel campo del giornalismo. Quand’ero piccola gli addetti all’informazione erano esclusivamente la carta stampa, la radio e la televisione (nello specifico, i telegiornali). La notizia veniva resa nota, e per quel giorno era tutto. Seguivano aggiornamenti all’occorrenza.
Nel 2025 (così come dagli anni 2000 in poi) la notizia del giorno non è più la notizia del giorno, ma la notizia del mese. C’è una differenza di proporzioni, si predilige la quantità piuttosto che concentrarsi sulla vera notizia (una saturazione di programmi televisivi titolati senza alcuna distinzione tra loro che servono solo a farsi concorrenza tra giornalisti). Anche a voler guardare un bel film prima di andare a nanna, come se ne davano in onda all’epoca, non lo si trova manco a impiccarsi. Nel piccolo schermo impazzano reality (dove anche qui di reale c’è poco e niente), fiction, programmi di inchiesta o approfondimento (quante volte dobbiamo scaldare ‘sta minestra?) e talk show politici (più che talk show andrebbero definiti per quello che sono davvero, ovvero killer show e hit show, più genericamente cumulabili nella categoria degli horror show).
Ora, è ovvio che tutta questa scorribanda del progresso, di internet, dell’avanzamento tecnologico, della informatizzazione di ogni aspetto della vita (si pensi alla giustizia dove il deposito degli atti e le udienze avviene online, ma anche le ricette mediche, l’invio dei modelli della dichiarazione dei redditi, così come la richiesta delle istanze da parte del cittadino che deve, obbligatoriamente, essere munito dell’identità digitale) abbia cambiato il nostro modo di vivere, di pensare e di agire, sia per ciò che concerne la sfera individuale ma, soprattutto, il nostro rapporto con gli altri. Non siamo più umani, siamo dei robot. Ci siamo trasformati in macchine per produrre (non creare, ma produrre), sporcare, accumulare, scansare, generare entropia in nome del Dio Denaro disconoscendoci e facendoci la guerra tra di noi. Detto in altro modo: ci stiamo (auto)distruggendo.
Discutiamo del conflitto tra Gaza e Israele, della Russia contro l’Ucraina, ma non ci accorgiamo che prima di parlare della guerra che accade in Europa e in Oriente (facendo finta che ci interessi qualcosa e sempre facendo finta di trovare delle soluzioni) dobbiamo preoccuparci della guerra che ci stiamo facendo tra di noi tramite questo sesto potere (social media) che incide non di poco sul nostro comportamento. Ci accavalliamo nelle opinioni, sgomitiamo, insultiamo, sputiamo in faccia quando non siamo d’accordo con l’altro perché quello che diciamo noi è legge e non ammettiamo il confronto, facciamo a gara a chi urla di più, a chi vende più libri, a chi fa più concerti (e poi cade in depressione), a chi recita in più film o a teatro, o a chi scrive l’articolo più chic e lo scrive per prima per la sua testata (scivolando in errori di battitura), col risultato di non aver fatto niente di utile per la società (a parte blaterare tanto per il piacere di dare fiato alla bocca) e di trovarsi con un nulla di fatto in mano, che è lo specchio del vuoto assoluto dell’era contemporanea che siamo costretti a sopportare per sopravvivere. L’ “utilità” è confusa con lo stare sui social, presenziare agli horror show (il più delle volte per promuovere un disco, uno spettacolo, un libro, un programma) e “dire la propria”, che poi non è mai un esprimere la propria opinione perché tanto la mia opinione è diventata l’opinione di tutti, e quando non è più di tutti diventa pretesto per litigare e scatenare polemiche senza giungere ad un esito. Basta scorrere le interviste di un qualsiasi Vip: letta una, le altre sono identiche. Quello che dici te, lo dico pure io. Nulla di nuovo all’orizzonte.
Fingiamo di concentrarci sui problemi che ci affliggono quando, al contrario, siamo solo concentrati su noi stessi e su cosa inventarci per stare al centro dell’attenzione e far parlare di noi. Quando ciò non avviene – o non c’è riuscita nell’intento di lasciare traccia di sé – si passa alla violenza. Anche quest’ultima viene fatta passare come un atto di ribellione nei confronti di un regime governativo che tende a riportare alla luce la politica dei fasci, ma il movente è molto più complesso di quanto appare.
Il nucleo della questione rimane invariato: se non ci fermiamo a pensare (ma pensare come azione, non come prima coniugazione del verbo pensare e stop), se non la smettiamo di correre per arrivare sempre primi o per il terrore di essere dimenticati e di non lasciare segni del nostro passaggio sulla Terra, non arriveremo a concludere niente se non continuare ad alimentare la merce del nulla, un passa-tempo in cui sguazzare che, invece di ancorarci alla realtà, mette sempre più distanza tra noi e l’esistenza, rendendoci esseri cattivi, assenti, deviati, depressi e “meccanizzati”.
E quel che è peggio manipolati dal sistema economico del consumismo, un enorme contenitore cavo di contenuto, che ha finito col consumarci.