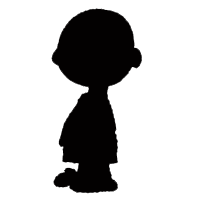
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
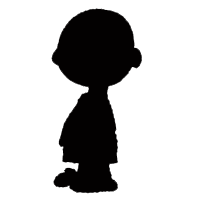
Charlie Brown
"Solo gli imbecilli non hanno dubbi"
"Ne sei sicuro ?"
"Non ho alcun dubbio!"
(Luciano De Crescenzo)
"Talvolta le parole ne nascondono altre".
(William Shakespeare)
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
"La ragazza silenziosa sta bene lì, non le manca niente. Soprattutto, non ha bisogno di niente.
Ed è la cosa più importante.
Perché vuol dire che non deve chiedere niente. È fondamentale.
Perché se chiedi qualcosa alle persone
prima o poi si presenterà qualcuno per riscuotere il favore".
(Donato Carrisi, La casa dei silenzi Longanesi Editore 2024)
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Mi chiamo Pietro Gerber ma qui a Firenze, dove vivo da quando sono nato, tutti mi conoscono come l’addormentatore di bambini. Sono un ipnotista, come lo era mio padre, e con l’ipnosi aiuto i bambini a elaborare traumi e a superare paure e fobie. Non sembrerebbe, ma il mio è un mestiere pericoloso. Perché la mente dei bambini è un labirinto ed è facile smarrirsi e non riuscire più a tornare. Forse è proprio questo che sta succedendo a Matias. Ha nove anni e da tempo ha un sogno ricorrente. Da troppo tempo. Ormai Matias ha paura di addormentarsi, perché in sogno gli fa visita qualcuno che non dovrebbe esistere. Una donna dall’aria triste e vestita sempre di scuro e che non parla mai. La signora silenziosa abita i suoi sogni come uno spettro, come una presenza inquietante che tracima nella realtà. Non dovrebbe essere nient’altro che un sogno, ma allora… Allora perché sento che la signora silenziosa è reale? Allora perché sento nel silenzio il ronzio di un immenso sciame di insetti? Allora perché sento che perfino la mia casa, vuota e solitaria, è infestata da fantasmi? E se la storia della signora silenziosa fosse ancora tutta da scrivere… Come la mia?
Mi chiamo Pietro Gerber, sono l’addormentatore di bambini, e di colpo ho paura di dormire. E ho ancora più paura di stare sveglio.
Questa è la storia di Matias Craveri che, da quanto si evince dalla seconda di copertina del romanzo, ha nove anni ed è tormentato da un incubo ricorrente. Da otto mesi nel suo sonno viene a fargli visita una signora vestita tutta di nero. La donna non parla, non gli fa alcun male; è molto triste e sente il bisogno di raccontargli una storia. Ma forse Matias la sua storia la conosce già.
Questa è la storia di Pietro Gerber, noto come l’addormentatore di bambini, al quale in passato molti genitori hanno affidato dei casi senza via d’uscita. Lui è la loro unica salvezza, l’unica speranza, l’ultimo tentativo che a loro resta per la salvaguardia dei loro cuccioli. Si occupa di estrarre dal loro inconscio ciò che più li spaventa, li angoscia, i mostri e i fantasmi che condizionano la loro vita e che si alimentano attraverso i loro sogni infettando la loro innocenza. È un lavoro di grossa responsabilità. Pietro sa che non sempre può riuscire a salvarli, ma c’è un rischio peggiore: quello di essere coinvolto nel loro mondo onirico e di rimanerne intrappolato. Dovrebbe essere abituato, avere il giusto distacco da ciò che ascolta e da ciò che lo circonda, dovrebbe conoscere quali sono le insidie visto che il signor B., suo padre, esercitava il suo stesso mestiere e lo portava ad essere sempre in contatto con i fantasmi altrui. Eppure, improvvisamente, anche Pietro comincia ad aver paura. Non riesce più a dormire. Ha paura di crollare, ha paura di stare sveglio. Non riesce più a capire dove finisce il confine della realtà con quello dei sogni, ammesso che esista un confine. Non sa se il silenzio da cui viene assalito quando entra in casa sua sia l’ombra dei suoi piccoli pazienti, oppure se a parlargli sia la sua ombra.
Questa è la storia della signora silenziosa di cui non si conosce il nome né il volto, solo la sua espressione che racconta di un vissuto sempre uguale. La signora silenziosa è una donna, abita i sogni di un bambino, un bambino a cui s’aggrappa per sopravvivere, per non essere dimenticata, un bambino per cui urlare. Matias si sveglia angosciato ogni volta che la vede, talvolta urla; dal loro primo incontro ha cominciato a spegnersi, appassendo come fanno i fiori. Non c’è più tempo, confessano Ivo e Susana Craveri a Pietro Gerber, bisogna far presto. Non c’è più tempo per chi, per Matias o per la signora silenziosa? Ma, soprattutto, la signora silenziosa esiste oppure è solo la visione di un bambino?
Questa è la storia di un silenzio, che non dice nulla ma ha tanto da raccontare.
È la storia di tre persone, quattro, sei, dieci e così via.
La casa dei silenzi è il nuovo, ipnotico, sconvolgente e mesto thriller di Donato Carrisi dove a essere in gioco, questa volta, non è solo la felicità e la libertà di un bambino.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Nutro una profonda urticaria per i romanzi rosa. Chiariamolo: non c’è nulla di male ad essere romantici, ma con moderazione (come in tutte le cose).
Quando ero una adolescente il genere letterario da me prevalentemente letto era il genere rosa. Poi sono guarita, ma sono stata condizionata per un bel po’ di tempo. La ragione – non mi piace definirla colpa – è ascrivibile a mia nonna, la quale era molto affezionata alle favole di principi e principesse che la portavano ad essere una romanticona. O forse era il contrario. Le piacevano le favole perché era lei ad essere romantica. Vabbè, fatto sta che aver trascorso molto tempo con lei durante la mia infanzia ha comportato una crescita esponenziale della mia immaginazione. Non era possibile che il “mondo fuori” fosse diverso dal “mondo fantasticato”, ma soprattutto che il primo fosse molto cattivo.
Ascoltandola mentre mi raccontava le sue favole mi convincevo sempre di più che da qualche parte, al di là di quelle mura domestiche, ci fosse il Principe Azzurro ad attendermi. Dovevamo solo pazientare: lui doveva essere bravo ad aspettare che io crescessi, e io altrettanto brava ad aspettare che crescessi per poterlo incontrare.
Quella bambina poi è cresciuta e, con grande rammarico, ha scoperto che il mondo fuori non era affatto uguale al mondo fantastico dove la nonna la accompagnava quasi tutti i giorni per fare dei bellissimi e indimenticabili viaggi, e ci è rimasta male. Non sa se prendersela con quella nonna che l’aveva tanto amata, si sente un po’ ingannata. Poi conta fino a dieci, sospende il giudizio (epoché, dal greco έποχή, “sospensione”) sulla dolce e tenerissima donna anziana e arriva alla conclusione che la nonna non ha nessuna colpa. L’unica colpa che ha è quella di averla amata tantissimo. E quando si ama tanto capita di cadere vittima dell’errore.
Dalle favole siamo passate alle telenovele, e dalle telenovele ai romanzi d’amore.
A proposito di telenovele, ricordo ancora come fosse ieri che un pomeriggio costrinse me e le mie amichette a guardare assieme a lei l’ultima puntata di Topazio; lei era seduta sulla sua solita sdraio dietro di noi, e noi sedute a terra a gambe incrociate, in fila per due (era estate), tutte concentrate manco stessimo guardando Sanremo. Nelle sue intenzioni – e in particolar modo, per un maggiore senso di sicurezza dei nostri genitori – era meglio che fossimo tenute sotto la stretta sorveglianza del suo occhio vigile piuttosto che scorrazzare in giro per le strade e i vicoli del quartiere dove eravamo solite giocare all’aria aperta a nascondino, a campana, a un, due, tre, stella e via dicendo.
Per quanto riguarda i romanzi rosa (che lessi fino ai primissimi anni di università poi, come facevo notare, uscii dal coma) non menziono le autrici. Il perché lo scoprirete leggendo.
Nel corso degli anni ho collaborato con diverse testate giornalistiche cartacee e online. Tra le tante c’è quella con Leggere:Tutti, rivista di libri e letteratura. Ergo, un po’ per la mia patologia/dipendenza legata ai libri, un po’ per l’onere (e l’onore) di assolvere al compito di cercare spunti interessanti per stendere gli articoli, mi viene naturale curiosare tra gli argomenti che stuzzicano la mia attenzione.
Succede questo. Circa una dozzina di anni orsono mi capita di leggere un’intervista di una giornalista inglese in cui analizzava con una psicologa (che era anche autrice di libri) i pro e i contro dei romanzi rosa. La conclusione a cui si giunse era questa: questo genere di lettura fa più male che bene perché, in sostanza, illude le lettrici. Inutile dire che il tema aveva destato il mio interesse perché quanto affermato dall’autrice collimava con le mie stesse considerazioni. Coincidenza vuole che dopo pochi giorni mi trovo a seguire la presentazione del libro di un’autrice di romanzi “romance” in una libreria di Roma. Al termine, chiedo alla referente della penna – impegnata ad elargire autografi alle sue affezionatissime e numerose lettrici – se è possibile avere il suo contatto per poter svolgere un’intervista dato che in quel momento risultava impossibile interloquire di persona stante l’ora, l’impegno e la stanchezza profusa per le sue fan giulive. Lo ottengo, e quando mi accingo a predisporre le domande non riesco a trattenermi dall’infilare una provocazione che assomiglia molto a quella della giornalista inglese, solo posta con più garbo.
La destinataria, all’atto della ricezione, non la prende bene. Non mi insulta, ma dal tenore della risposta capisco che era suo desiderio farlo perché è piuttosto stizzita. Incasso la reiezione dell’intervista e tutto finisce lì. Tuttavia, seppur consapevole che la domanda pruriginosa l’avrebbe infastidita speravo nel colpo di scena, e cioè che alla mia provocazione rispondesse con la stessa provocazione, oppure zittendomi con una risposta arguta.
Non ho più avuto occasione di incontrare l’autrice (che ha sempre avuto un enorme riscontro di pubblico e continua ad averlo).
2024. Notizia di quattro/cinque mesi fa. Su uno dei più noti quotidiani italiani la famosa autrice, in una intervista, confessa lei stessa di scrivere “ciofeche”. Adopera proprio questa parola: ciofeca. Per chi non lo sapesse, “ciofeca” o “ciufeca” è, secondo l’enciclopedia Treccani, un etimo incerto, probabilmente di origine spagnola (dal termine chufa) che indica una mandorla amara per fare un’orzata; il nome invece deriverebbe dall’arabo safek e sta a significare una bevanda (vino o caffè) di pessimo sapore, broda, porcheria, schifezza. Non proprio una definizione di tutto rispetto, insomma.
Sorrido divertita. Non so se è l’età che dà maggiore consapevolezza ad un individuo o se al tempo la beccai in un momento poco adatto, comunque sia la prima cosa che penso è: “E io che ti ho chiesto tanti anni fa?”. Certo, non le domandai: “Carissima Signora, è vera questa cosa che i romanzi rosa fanno cagare, non sono utili a nessuno e, pertanto, visto che fa parte della cerchia degli autori romance anche ciò che scrive lei è da reputarsi come una vera e propria schifezza?”.
Nulla, nulla di tutto ciò. Mi limitai solo a domandarle se era d’accordo con le conclusioni giunte all’analisi dell’intervistatrice e della psicologa riguardo al genere letterario rosa (le avevo accennato a quell’articolo che lessi), e quali erano le sue opinioni al riguardo.
A distanza di anni non solo scopro che, in fondo in fondo, la mia non era una domanda sbagliata, ma qui (o all’epoca in cui si svolsero i fatti) se c’è qualcuno che “offende” o “aveva offeso”, quel qualcuno non fu la sottoscritta, anzi. Chi parla del proprio lavoro usando una terminologia dispregiativa è lo stesso soggetto che si sentì offesa. Affermare di scrivere ciofeche è come ammettere di essere un’autrice veramente scarsa.
Vorrei fare un appunto. Ho scritto “non so se al tempo la beccai in un momento poco adatto” perché è vero che la beccai, nel senso letterale del termine. Sebbene posi la domanda in modo educato, era tutto sommato una provocazione. In pratica è come chiedere ad un autore di gialli “ma perché scrive di morti ammazzati quando già siamo circondati da una cattiveria infinita? Non crede che così facendo contribuisce ad aumentare il tasso di criminalità?”, che può essere recepita come un’offesa, chiamiamola così, oppure un’accusa.
C’è una differenza tra le due cose, una grossa differenza. I detrattori reputeranno una apologia a favore dei giallisti quanto sto per dire.
Gli assassini esistono. I mostri esistono. Le vittime esistono. È un horror, un incubo a cui assistiamo tutti i santi giorni. Siamo bombardati dalla cronaca nera. Ci abbuffano di omicidi, violenze, stupri, risse, furti, minacce. La cosa assurda – e preoccupante – è che queste perversioni non ci vengono mai a nausea, sia da parte di chi li commette, sia da parte dello spettatore che gode dello spettacolo della morte. Siamo un popolo di ingordi della morte e della violenza.
Il Principe Azzurro, invece, non esiste. Ci abituano e ci insegnano a crescere convincendoci del contrario. Quello che dovremmo imparare, su cui dovremmo allenarci ed esercitarci è la capacità di discernimento: comprendere ciò che è favola, da ciò che favola non è. Basta illusione, basta evasione. Se c’è qualcosa da cui evadere sono gli stereotipi.
I libri, l’arte, la scienza, la matematica, la filosofia, i viaggi, le lingue, la cultura servono a questo. Ad apprendere, imparare, a crescere e a migliorare.
*Il titolo si riferisce alla trama del thriller di Donato Carrisi, La casa dei silenzi di ultimissima pubblicazione con la Longanesi Editore. Lo “scarafaggio” è un essere molto pericoloso che, il più delle volte, si stenta a riconoscere perché è bravissimo a mascherarsi e ad assumere l'aspetto di “salvatore”.
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Accedi o Registrati per commentare l'articolo
Seguo sedute psichiatriche, non spiritiche.
(Charlie)